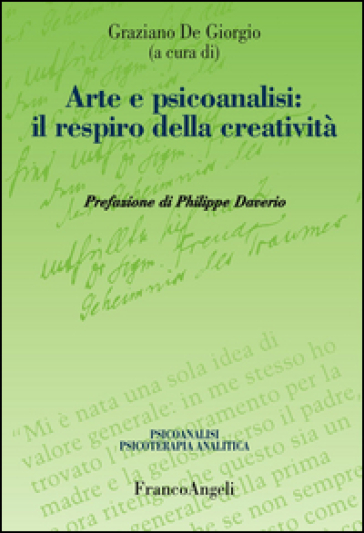Ulteriorità Precedente
Pagine
mercoledì 31 agosto 2022
giovedì 3 ottobre 2019
Sul Perturbante. Attualità e trasformazioni di un'idea freudiana nella società e nella clinica psicoanalitica di oggi, Mimesis Edizioni, 2019.
Ecco il mio nuovo libro sul Perturbante, da oggi in libreria, per i tipi di Mimesis Edizioni, Milano, nella collana "Attualità del pensiero psicoanalitico" diretta da Antonino Ferro. Contiene un'ottima prefazione di Giuseppe Civitarese e un'altrettanto ottima introduzione di Giuseppe Pellizzari nonché, nei ringraziamenti, un mio sentito ricordo di Elvezio Sciallis. Segnalo qui il link di Mimesis dove troverete scheda tecnica, quarta di copertina e possibilità di eventuale acquisto online: http://mimesisedizioni.it/libri/psicologia-scienze-educazione-didattica/attualita-del-pensiero-psicoanalitico/sul-perturbante.html
Spero vi piaccia. Fatemi sapere.
domenica 22 settembre 2019
venerdì 27 ottobre 2017
It (Capitolo Uno), di Andy Muschietti (2017)
Siamo
nel 1989, in una giornata d’autunno, a Derry, piccola e sonnolenta
cittadina nel Maine. Una tremenda alluvione ha allagato le strade, e
per il piccolo George Denbrough questa è un’ottima occasione per
provare la barchetta di carta che gli ha costruito il fratello Bill.
Georgie esce nella pioggia con il suo impermeabile giallo, e si
diverte a correre inseguendo la sua barchetta di carta trascinata dai
rivoli d’acqua verso i canali di scolo e i tombini delle vie della
città. Improvvisamente la barchetta finisce però in un tombino e
Georgie si china per riprendersela. Dal fondo del tombino spuntano
due vispi occhi azzurri e la faccia di un clown da circo, che dice di
chiamarsi Pennywise ed offre un palloncino rosso al bambino. Georgie
tende la mano per riprendersi la barchetta, ma Pennywise gli mostra
la sua forma diabolica, divorandogli un braccio e lasciandolo riverso
sulla strada bagnata, privo di vita. Bill,
il fratello preadolescente di Georgie, vuole a tutti costi scoprire
cosa sia accaduto e insieme ai suoi amici del cuore Richie Tozier,
Eddie Kaspbrak, Stan Uris, Beverly Marsh, Mike Hanlon e Ben Hanscom,
comincia a dare la caccia al clown assassino. Lungo il corso di tutto
il romanzo scopriranno loro malgrado che Pennywise è l’incarnazione
dell’anima maligna della città di Derry, che ogni ventotto anni
torna in superficie per riprendere vita nutrendosi di bambini. Unendo
le loro forze in una sorta di “cerchio magico” iniziatico,
chiamato “il club dei Perdenti”, i ragazzi riusciranno a
respingere gli attacchi del sanguinario It, promettendo di ritrovarsi
ventotto anni dopo per affrontare ancora una volta il Male che
possiede Derry e sconfiggerlo definitivamente.
“(…)
il sacrificio della memoria e del desiderio conduce
alla
crescita della ‘memoria’ sognante, che è una parte
dell’esperienza
della realtà psicoanalitica”.
W.R.
Bion
Attenzione
e interpretazione (1971)
“(…)
Ragazzi, il romanzesco è la verità dentro la bugia,
e
la verità di questo romanzo è semplice:
la magia esiste”.
Stephen
King
It
(1986)
La
prima parola che mi è venuta in mente
dopo
aver visionato “It”, ultima fatica dello statunitense Andy Muschietti, è stata l’aggettivo “esegetico”. Un aggettivo che
di solito riguarda l’esegesi biblica, oppure gli studi sui testi sacri
nell’ambito della storia delle religioni. Riflettendoci sopra
successivamente tale aggettivo non mi è parso poi così anomalo,
poiché
il film è un vero,
sentito, autentico omaggio al grande e corale romanzo omonimo di
Stephen King, pubblicato nel 1986.
Il libro di King è infatti una sorta di Summa Theologica contemporanea, forse la più rappresentativa, del genere Perturbante in letteratura. King vi si dedica ininterrottamente per quattro anni consecutivi, arrivando a scrivere 1238 pagine nelle quali descrive in modo denso ed evocativo i fantasmi e i mostri che maggiormente possono inquietare un bambino, e di cui il film di Muschietti racconta la prima parte, aiutato dagli ottimi sceneggiatori Cary Fukunaga, Chase Palmer e Gary Dauberman, dal montaggio fluido e coinvolgente di Jason Ballantine, nonché dalla fotografia, sobria e delicata di Chung-hoon Chung . Leggendo il romanzo, a tratti sembra che la scrittura abbia per King il significato di un esorcismo delle sue stesse angosce, che pescano profondamente nell’idea stessa di crescita come trauma, come processo iniziatico molto doloroso (l’infanzia e l’adolescenza dello scrittore sono state in verità attraversate da tragiche vicende di abbandono e di morte. Notizie più approfondite in merito si possono trovare semplicemente digitando il nome di King su Google).
Nel romanzo è evidentissima l’ispirazione a H.P. Lovecraft e alla sua poetica neogotica, una poetica che si pone in continuità con quella di Edgar Allan Poe, e la sviluppa all’interno di un’orizzonte che potremmo definire antesignano di un esistenzialismo filosofico declinato in ambito letterario. Sia in King che in Lovecraft il Male di vivere diventa infatti “immanenza” eterna che abita il quotidiano di soffitte e cantine delle case della provincia americana e da lì perseguita l’uomo. Un Unheimlich immanente quindi, spinoziano, che si manifesta come “familiare” e che si fa improvvisamente estraneo, vero “mostro della porta accanto”. Nel caso di “It” è un’intera città, Derry, ad essere posseduta dal monstrum.
Il libro di King è infatti una sorta di Summa Theologica contemporanea, forse la più rappresentativa, del genere Perturbante in letteratura. King vi si dedica ininterrottamente per quattro anni consecutivi, arrivando a scrivere 1238 pagine nelle quali descrive in modo denso ed evocativo i fantasmi e i mostri che maggiormente possono inquietare un bambino, e di cui il film di Muschietti racconta la prima parte, aiutato dagli ottimi sceneggiatori Cary Fukunaga, Chase Palmer e Gary Dauberman, dal montaggio fluido e coinvolgente di Jason Ballantine, nonché dalla fotografia, sobria e delicata di Chung-hoon Chung . Leggendo il romanzo, a tratti sembra che la scrittura abbia per King il significato di un esorcismo delle sue stesse angosce, che pescano profondamente nell’idea stessa di crescita come trauma, come processo iniziatico molto doloroso (l’infanzia e l’adolescenza dello scrittore sono state in verità attraversate da tragiche vicende di abbandono e di morte. Notizie più approfondite in merito si possono trovare semplicemente digitando il nome di King su Google).
Nel romanzo è evidentissima l’ispirazione a H.P. Lovecraft e alla sua poetica neogotica, una poetica che si pone in continuità con quella di Edgar Allan Poe, e la sviluppa all’interno di un’orizzonte che potremmo definire antesignano di un esistenzialismo filosofico declinato in ambito letterario. Sia in King che in Lovecraft il Male di vivere diventa infatti “immanenza” eterna che abita il quotidiano di soffitte e cantine delle case della provincia americana e da lì perseguita l’uomo. Un Unheimlich immanente quindi, spinoziano, che si manifesta come “familiare” e che si fa improvvisamente estraneo, vero “mostro della porta accanto”. Nel caso di “It” è un’intera città, Derry, ad essere posseduta dal monstrum.
Il
film di Muschietti riprende tutta questa poetica, e compie il
miracolo di una trasposizione (anche qui userei il termine di stampo
religioso di “trasfigurazione”) di tanto e denso materiale
immaginifico all’interno di una pellicola di 135 minuti. Costretto
da tale tempistica, nonché dai limiti intrinseci di business delle
case di produzione (essenzialmente New
Line e Warner Bros.),
Muschietti riesce comunque a rimanere esegeticamente fedele al testo,
trasmettendo emozioni e intenti profondi che vengono da un autore,
King, che
da sempre pone al centro della sua poetica l’infanzia e il dolore
per la sua perdita durante il percorso di crescita e di
soggettivazione adolescenziale. Uno degli ingredienti fondamentali
del Perturbante, nell’accezione freudiana del termine, consiste, com’è noto,
nel suo attingere i principali motivi che lo ispirano, all’infanzia
come motore della sessualità e della relazionalità adulta, e in
questo senso il romanzo di King è assolutamente ascrivibile al
Perturbante.
Il cuore narrativo dell’intero romanzo, così come del film di Muschietti, può essere agevolmente rappresentato dalla metafora dell’”iniziazione”, del “rito di passaggio” dall’infanzia all’età adulta, una ritualità che passa attraverso il dolore del lutto e del “ritorno del rimosso” infantile nell’età adulta. “It” è infatti costruito su due piani temporali paralleli e non lineari: il 1957, cioè l’infanzia dei protagonisti, che poi ritroviamo nel 1984, quando sono diventati grandi. Muschietti, saggiamente, ambienta il film nel 1989, per poi farci pensare ad una prossima pellicola che ambienterà ai giorni nostri. Il film declina molto bene sul piano espressivo-estetico, con grande attenzione al rapporto tra “mondo dei bambini” e “mondo degli adulti”, il tema dell’abbandono e delle disfunzionalità familiari, tutti aspetti peraltro ricorrenti anche nella copiosa produzione letteraria di King.
Il cuore narrativo dell’intero romanzo, così come del film di Muschietti, può essere agevolmente rappresentato dalla metafora dell’”iniziazione”, del “rito di passaggio” dall’infanzia all’età adulta, una ritualità che passa attraverso il dolore del lutto e del “ritorno del rimosso” infantile nell’età adulta. “It” è infatti costruito su due piani temporali paralleli e non lineari: il 1957, cioè l’infanzia dei protagonisti, che poi ritroviamo nel 1984, quando sono diventati grandi. Muschietti, saggiamente, ambienta il film nel 1989, per poi farci pensare ad una prossima pellicola che ambienterà ai giorni nostri. Il film declina molto bene sul piano espressivo-estetico, con grande attenzione al rapporto tra “mondo dei bambini” e “mondo degli adulti”, il tema dell’abbandono e delle disfunzionalità familiari, tutti aspetti peraltro ricorrenti anche nella copiosa produzione letteraria di King.
Per
tutti questi motivi, tanto
il film quanto il romanzo, credo contengano
valenze e
vettori di senso
che possono molto interessare uno psicoanalista. Ho citato infatti il
Bion di “Attenzione e interpretazione” in esergo, a fianco della
dedica iniziale di “It”, non a caso. Non
credo che Stephen King stesse leggendo il Bion di “Attenzione e
interpretazione” (1970) nel momento in cui si accostava alla
scrittura del suo più poderoso ed evocativo romanzo, “It”,
iniziato a Bangor, nel Main, il 9 settembre 1981, e terminato nella
stessa città il 28 dicembre 1985. Nè, tanto
meno,
Bion ebbe la possibilità di leggere il romanzo horror
dello scrittore statunitense, considerato che lo psicoanalista
inglese morì nel 1979. “It” contiene tuttavia molte suggestioni
che probabilmente avrebbero incuriosito Bion, sopratutto il Bion
della cosiddetta “fase estetica”, a partire dalla dedica iniziale
del romanzo che King indirizza ai suoi figli, Naomi Rachel, Joseph
Hillstrom e Owen Philip, esortandoli ad una sorta di “visione
binoculare”, in cui “bugia” e “verità” assumono una
valenza conoscitiva di natura “oscillatoria”, appunto
“binoculare”, attraverso il veicolo del genere romanzesco. “Il
romanzesco è la verità dentro la bugia” (King,
1986),
tema, quello della “bugia”, come si sa, molto caro a Bion, i cui
riferimenti a poeti e letterati come portatori inconsapevoli di
verità, sono molteplici nella sua opera.
Sul
piano tecnico, dell’allestimento, e dell’architettura filmica
complessiva, il “miracolo” di Muschietti è soprattutto
incentivato da un casting magistrale,
mirabilmente condotto
da Rich Delia,
nel
quale risplende di una luce particolare il personaggio di Beverly
Marsh (una Sophia Lillis che certamente ne farà di strada, perbacco),
la ragazzina dai capelli rossi, suo malgrado immersa in una relazione
incestuale con un padre che fa diventare la “confusione delle
lingue tra adulto e bambino” (Ferenczi,1932) il
suo principale strumento di comunicazione perversa.
Muschietti ci accompagna all’interno di un “gruppo dei pari” (il club dei Perdenti) che diventa l’unica àncora di salvataggio di Beverly ma anche degli altri giovani amici uniti nella lotta contro Pennywise, rappresentazione polimorfa del vuoto affettivo che circonda la crescita di questi ragazzi. Pennywise (interpretato da un Bill Skarsgård incredibilmente capace di personificare il demoniaco semplicemente attraverso uno sguardo), è infatti una perfetta rappresentazione, raramente visibile in un film, di quello che potremmo chiamare il “furto della soggettivazione” di un individuo fragile come può essere appunto un preadolescente, da parte di un ambiente “adulto” incapace di ascoltare, di accompagnare la crescita, di nutrirla attraverso i giusti dosaggi di “verità” e di “bugia”.
Muschietti ci accompagna all’interno di un “gruppo dei pari” (il club dei Perdenti) che diventa l’unica àncora di salvataggio di Beverly ma anche degli altri giovani amici uniti nella lotta contro Pennywise, rappresentazione polimorfa del vuoto affettivo che circonda la crescita di questi ragazzi. Pennywise (interpretato da un Bill Skarsgård incredibilmente capace di personificare il demoniaco semplicemente attraverso uno sguardo), è infatti una perfetta rappresentazione, raramente visibile in un film, di quello che potremmo chiamare il “furto della soggettivazione” di un individuo fragile come può essere appunto un preadolescente, da parte di un ambiente “adulto” incapace di ascoltare, di accompagnare la crescita, di nutrirla attraverso i giusti dosaggi di “verità” e di “bugia”.
Qui ho detto alcune cose, molte ancora avrei da dire su questo film commovente, epocale. Ma lo spazio della scrittura di una recensione non è infinito, quindi vi rimando, per ulteriori stimoli di riflessione, alla sempre ottima recensione di Lucia Patrizi.
Regia: Andy Muschietti Soggetto e Sceneggiatura: Cary
Fukunaga, Chase Palmer, Gary Dauberman Casting Director: Rich Delia Fotografia: Chung-hoon Chung Musiche: Montaggio: Jason Ballantine Nazione: USA, Canada Produzione: New Line Cinema, Warner Bros. Durata: 135 min.
lunedì 10 luglio 2017
Letture estive 2017
Come di consueto, con l'avvicinarsi dell'estate, cioè di quell'oasi sempre e comunque breve, in cui riposiamo le nostre stanche membra su spiagge il più possibile cristalline, oppure all'ombra di una quercia secolare, su qualche picco montano, ecco che attraverso il blog, giungo a proporvi alcune letture estive a mio avviso utili ad accompagnarci nel corso della nostra inesausta ricerca di un meritato riposo. E' anche un'occasione per riprendere in mano le sorti di questo ormai desertico blog, cui ho pochissimo tempo da dedicare, cosa che mi dispiace molto.
Comincio anche a provare invidia verso alcuni amici blogger, e soprattutto per la portentosa amica Lucia Patrizi, che riesce a postare valanghe di recensioni interessantissime ogni giorno che passa, magari dopo aver fatto 25 chilometri in bicicletta, e per di più in salita.
E' vero che in questi ultimi anni ho scritto due libri, uno da solo e l'altro con colleghi, più vari articoli. E' vero anche che questo è stato un anno in cui ho svolto 5 conferenze e interventi pubblici di vario tipo in vari luoghi. E' vero che sono impegnato su vari fronti professionali, ma una potenza di fuoco come quella della Lucia Patrizi non ha in sè assolutamente rivali. Da qui la mia invidia, naturalmente. Ma cominciamo con i titoli di cui vi parlavo.
Comincio anche a provare invidia verso alcuni amici blogger, e soprattutto per la portentosa amica Lucia Patrizi, che riesce a postare valanghe di recensioni interessantissime ogni giorno che passa, magari dopo aver fatto 25 chilometri in bicicletta, e per di più in salita.
E' vero che in questi ultimi anni ho scritto due libri, uno da solo e l'altro con colleghi, più vari articoli. E' vero anche che questo è stato un anno in cui ho svolto 5 conferenze e interventi pubblici di vario tipo in vari luoghi. E' vero che sono impegnato su vari fronti professionali, ma una potenza di fuoco come quella della Lucia Patrizi non ha in sè assolutamente rivali. Da qui la mia invidia, naturalmente. Ma cominciamo con i titoli di cui vi parlavo.
Questo libro si meriterebbe in verità una lunga recensione, non solo queste due righe di commento. Dal mio punto di vista l'ho trovato un libro straordinario. Il fisico teorico Carlo Rovelli è uno dei massimi studiosi italiani di "gravità quantistica a loop", membro dell'Institut universitaire de France e dell'Académie international de philosophie des sciences, è inoltre responsabile dell'èquipe di gravité quantique del Centre de physique theorique dell'Università di Aix-Marseille. Riesce in questo libriccino ad essere divulgativo e metaforico al massimo grado possibile rispetto alla complessità teorico-filosofica che ci vuole raccontare. E' un libro entusiasmante (difficile in alcuni punti, che però si possono tranquillamente saltare, sebbene io suggerisca di leggere tutto: tanto poi l'inconscio del lettore capisce lo stesso), che ci parla del nostro rapporto col tempo. Non è un libro solo scientifico, contiene anche molte profondissime riflessioni di ordine filosofico e sulla natura della soggettività umana, dai toni addirittura struggenti e poetici, in alcuni punti, come questo: "Il nostro presente pullula di tracce del nostro passato. Noi siamo storie per noi stessi. Racconti. Io non sono questa istantanea massa di carne sdraiata sul sofà che batte la lettera 'a' sul computerino portatile; (...) sono le carezze di mia madre, la dolcezza serena con cui mio padre mi ha guidato, sono i miei viaggi adolescenti, le mie letture che si sono stratificate nel mio cervello, i miei amori, le mie disperazioni, le mie amicizie, le cose che ho scritto, ascoltato, i volti che sono impressi nella mia memoria" (p. 152). Notevole. Davvero notevole. Un libro da portarsi in vacanza come un prezioso dono del pensiero umano, da leggere possibilmente su un'isola deserta, all'ombra di una palma, perdendosi tra le sue pagine, mentre ogni tanto si solleva lo sguardo per guardare il mare di fronte a noi.
Gunnar Staalesen, padre del giallo norvegese è naturalmente molto conosciuto in patria, dove scrive dagli anni '70, ma molto meno conosciuto da noi, dove Iperborea sta cominciando a tradurre la sua sua sterminata produzione di libri gialli che hanno come protagonista il romantico detective privato Varg Veum. Drammaturgo e scrittore di pieces teatrali, Staalesen crea un personaggio molto originale, lontano dal classico e risaputo detective dal passato traumatico e controerso. Varg Veum ha invece un passato da Assistente Sociale, si prende a cuore i suoi clienti e svolge il suo lavoro con una inclinazione particolare per il sociale. In questo romanzo (del 1981, ma che sembra scritto l'altro ieri), Veum è alle prese con una losca banda di affaristi che tengono in pugno Stavanger, città arricchitasi improvvisamente grazie al petrolio. Troverà addirittura il cadavere di una donna in un frigorifero, e ci porterà, attraverso continui colpi di scena, verso un finale assolutamente imprevedibile.
Un libro per psicoanalisti? Forse sì, ma anche per chi psicoanalista non è. Dal sottotitolo molto evocativo e ossigenante, il saggio curato da Graziano di Giorgio, contiene interessantissimi contributi di molti analisti italiani assai attivi nell'ambito della psicoanalisi dell'arte. Contributi di: Hugo Aisemberg, Cecilia Alvarez, Simona Argentieri, Stefano Bolognini, Giorgio Callea, Marta Capuano, Domenico Chianese, Giuseppe Civitarese, Philippe Daverio, Graziano De Giorgio, Paola Golinelli, Rita Manfredi Gervasini, Elisabetta Marchiori, Valeria Egidi Morpurgo, Fausto Petrella, Stefano Pozzoli, Cosimo Schinaia. Dalla presentazione del libro sulla pagina di Franco Angeli: "Le parole, il discorso verbale possono esprimere tutto? O vi sono esperienze che le parole non riescono a veicolare, né a farci sentire? Il contatto con le realtà umane più profonde, ci dice la psicoanalisi, provoca eccitazione ed emozioni che vanno dal piacere al sollievo fino all'angoscia e al terrore. I sogni e le fantasie possono creare uno schermo che protegge dall'incontro ravvicinato con sentimenti troppo intensi e dal perturbante di freudiana memoria.
La stessa funzione ce l'hanno le opere d'arte e le produzioni artistiche: dalle arti visive, al cinema, alla parola letteraria, alla musica. La creatività umana prende forma conoscibile e comunicabile nei sogni e nelle fantasie così come nelle rappresentazioni artistiche. Queste costituiscono il respiro della psiche, e permettono l'avvio di un lavoro di elaborazione e di trasformazione dei materiali psichici grezzi perché, come i sogni e le fantasie, sono portatrici di elementi inconsci universali. In virtù della loro struttura dinamica, le produzioni e rappresentazioni artistiche non solo danno voce a sentimenti ed emozioni ma costituiscono il mezzo attraverso cui un osservatore può riconoscere un movimento psichico originario.
Sono quindi i linguaggi dell'arte, nelle varie forme espressive, a suggerirci sentieri nuovi per avvicinarci alla lingua segreta della psiche. Nel suo seminario parigino del 1978 Wilfred Bion comparava gli psicoanalisti all'artista e invitava gli psicoanalisti a riflettere in quale tipo di impresa essi fossero coinvolti: "Che tipo di artista siete voi? Vasai, pittori, musicisti, scrittori? Nella mia esperienza, alcuni psicoanalisti non sanno che tipo di artista essi siano... Se essi non riescono a vedere loro stessi come artisti, essi stanno sbagliando lavoro".
Ritornare ad incontrare la creatività, in questo periodo in cui lo spazio e il respiro del pensiero e dell'arte sembrano sempre più sequestrati dall'economia, mi sembra un obiettivo essenziale, soprattutto durante lo spazio delle vacanze estive.
Il ritorno di Harry Hole in un romanzo giallo che non ho ancora letto, ma che mi è stato consigliato da alcuni pazienti. Jo Nesbø in questo romanzo sembra voler ridimensionare la figura del controverso detective della polizia di Oslo, amante dell'alcool e delle situazioni più pericolose da cui fa spesso fatica a stare alla larga. Infatti lo allontana dal vizio alcolico e lo mette a fare l'insegnante presso la scuola di polizia. Ma naturalmente tale ridimensionamento non può reggere all'entropia narrativa che caratterizza lo stile dello scrittore scandinavo. Hole si lascia ben presto coinvolgere nelle indagini relative alla morte violenta di due donne. Da qui nascerà tutto l'intreccio che questa nuova crime story sembrerebbe egregiamente estrinsecare. Mi ero in verità decisamente allontanato da Nesbø dopo alcune sue prove secondo me molto deludenti (vedi ad esempio il pessimo e noiosissimo "Il pipistrello"), ma siccome mi fido del fiuto dei miei pazienti, nonchè di quello di Andrea, il mio libraio di fiducia, ritorno a lui speranzoso.
Confesso che non amo affatto il Maurizio De Giovanni della serie del commissario Ricciardi, tanto quanto lo amo per la serie de "I Bastardi di Pizzofalcone". E non lo amo semplicemente perché non mi piacciono i romanzi a sfondo storico (non chiedetemi il perché: non lo so nemmeno io. Fatto sta che preferisco decisamente i romanzi che guardano al presente e al futuro, vedi ad esempio Jonathan Lethem, di cui parlerò più sotto). Enunciata questa premessa, non posso tuttavia non segnalare quest'ultimo libro di De Giovanni, della serie Ricciardi, primo perché mia moglie ama questo personaggio di amore infinito (e forse questo è un altro dei motivi per cui io non lo sopporto...), secondo perché (segue spoiler: ATTENZIONE!), se ho capito bene questo dovrebbe essere l'ultimo libro che chiude il ciclo della serie. In attesa di un nuovo libro dei "Bastardi", possiamo dunque dare un'occhiata anche a questo.
Thomas Ogden è uno tra gli psicoanalisti più in vista nel panorama analitico internazionale. Dopo Grotstein forse il clinico più fine, sensibile e che più di ogni altro sa interpretare e portare avanti l'insegnamento di Wilfred Bion. Questo libro è molto denso, toccante, commovente soprattutto nelle lunghe vignette cliniche presentate, che ci mostrano un analista "immersivo", nel pieno del suo lavoro e del suo coinvolgimento inconscio e cosciente all'interno della seduta. Raro trovare scritti psicoanalitici di questo tipo, e ancor più raro incontrare una generosità espositiva di tale genere. Interessante poi l'idea-cardine sulla quale si muove tutto il libro: che l'inconscio sia da trovare nel futuro, e in ciò che di "nuovo" si muove nello spirito dell'uomo, non tanto nel passato, come sosteneva Freud. Non lo si può definire certamente un "libro da ombrellone", ma se si ha tempo a disposizione è un vero peccato non dedicargliene. E l'estate si ha di solito più tempo a disposizione
Thomas Ogden è uno tra gli psicoanalisti più in vista nel panorama analitico internazionale. Dopo Grotstein forse il clinico più fine, sensibile e che più di ogni altro sa interpretare e portare avanti l'insegnamento di Wilfred Bion. Questo libro è molto denso, toccante, commovente soprattutto nelle lunghe vignette cliniche presentate, che ci mostrano un analista "immersivo", nel pieno del suo lavoro e del suo coinvolgimento inconscio e cosciente all'interno della seduta. Raro trovare scritti psicoanalitici di questo tipo, e ancor più raro incontrare una generosità espositiva di tale genere. Interessante poi l'idea-cardine sulla quale si muove tutto il libro: che l'inconscio sia da trovare nel futuro, e in ciò che di "nuovo" si muove nello spirito dell'uomo, non tanto nel passato, come sosteneva Freud. Non lo si può definire certamente un "libro da ombrellone", ma se si ha tempo a disposizione è un vero peccato non dedicargliene. E l'estate si ha di solito più tempo a disposizione
Non so se ve lo avevo già detto, ma io amo Jonathan Lethem, soprattutto il Lethem dei racconti, e vedi soprattutto la meravigliosa raccolta "L'inferno comincia nel giardino" (2001, Minimum Fax). I suoi racconti, più che i romanzi posseggono uno stile variegato. Il newyorkese è capace di utilizzare stilemi e generi letterari tra i più vari per dipingere affreschi narrativi che spaziano dall'horror al fantascientifico, al giornalistico, all'elegiaco, sempre con l'obiettivo di dipingere l'imprevedibilità proteiforme e spesso inquietante della vita umana. In questa raccolta leggiamo molte storie: un padre con l'esaurimento nervoso perché le vacanze di famiglia iniziano a prendere una piega sinistra; un critico del porno che, nonostante le migliori intenzioni, viene perseguitato dalla sua fama - oltre che dalla montagna di oscenità che riempiono il suo appartamento; una banda di personaggi di vecchi fumetti bloccati su un'isola deserta; un neonato portato in salvo durante una tempesta di neve; un prigioniero politico in un buco di una strada cittadina. La creatività letteraria di Lethem è stupefacente: da manovrare con cura quindi, e da prendere a piccole dosi, soprattutto d'estate, proprio come un buon vino bianco sorseggiato sotto il sole cocente di una spiaggia greca. Un racconto al giorno, cioè, direi che è più che sufficiente.
Chiudiamo questa lista (nè lunga nè corta) di piccoli suggerimenti libreschi per l'estate con questo gustosissimo e insieme profondissimo libro di Antonino Ferro, insieme a Ogden e a Bollas, uno dei maggiori maestri viventi della psicoanalisi contemporanea, che ho l'onore di conoscere personalmente. Il libro è curato dall'amico carissimo e collega modenese Luca Nicoli, mente tanto giovane quanto creativa e vivace, che pone molte domande a Ferro circa le trasformazioni (a tratti rivoluzionarie) cui è andata incontro la Psicoanalisi negli ultimi vent'anni. Libro in apparenza molto irriverente nei confronti di Freud, ma che in realtà ne sottolinea (a mio avviso inconsapevolmente) il ruolo di apripista di sentieri poi esplorati da molti altri maestri. Il vero piacere nel leggere questo libro sta nello scoprire la capacità di Ferro di creare metafore e produrre immagini assai pregnanti per descrivere le modificazioni teoriche e tecniche cui è andata incontro la psicoanalisi contemporanea intesa come cura della sofferenza psichica dei pazienti che le si rivolgono.
Bè, a questo punto direi che auguro ai miei 25 lettori un'estate piena di emozioni profonde, sentite, e di relazioni piacevoli e arricchenti. Buone vacanze!
Bè, a questo punto direi che auguro ai miei 25 lettori un'estate piena di emozioni profonde, sentite, e di relazioni piacevoli e arricchenti. Buone vacanze!
venerdì 19 maggio 2017
Alien Covenant, di Ridley Scott (2017)
Nel flashback introduttivo Sir Peter Weyland, fondatore della Weyland Corporation, si rivolge ad un androide che entra a far parte della spedizione Prometheus. Weyland chiede all'androide di scegliere un nome per se stesso e lui sceglie 'David'.
Nel 2104 l'astronave USCSS Covenant, in missione di colonizzazione planetaria, è in viaggio verso il pianeta Origae-6 con a bordo oltre 2.000 coloni in stato di ipersonno. Una tempesta di neutrini colpisce l'astronave provocando ingenti danni e la morte di 47 coloni oltre a quella del capitano Branson. L'androide Walter si ritrova così costretto a svegliare l'equipaggio dal sonno criogenico.
Il primo ufficiale della Covenant, Chris Oram, assume il comando della missione. Mentre sta riparando l'astronave, l'equipaggio intercetta una trasmissione radio proveniente da un vicino pianeta e decide di indagare sulla sua provenienza.
Raggiunto il pianeta, Tennessee, Ricks e Upworth rimangono a bordo della Covenant in orbita nello spazio mentre il resto dell'equipaggio si dirige sul pianeta per esplorarlo. Essi si ritrovano su un pianeta verdeggiante privo però di forme di vita animali. Durante l'esplorazione, un membro della squadra di sicurezza, Ledward, calpesta piccoli baccelli neri, causando la fuoriuscita di alcune spore che penetrano nel suo orecchio senza che egli se ne accorga. Nel corso di ulteriori ricerche la squadra scopre il relitto di un'astronave precipitata e al suo interno trova una piastrina identificativa appartenuta ad una certa "Dr.ssa E.Shaw" nonché la fonte della trasmissione che hanno captato. Ledward inizia a sentirsi male e Karine lo riconduce alla navetta di sbarco. Karine lo porta con urgenza nell'infermeria della navicella. Dalla schiena di Ledward fuoriesce una mostruosa creatura aliena, il Neomo che aggredisce ed uccide Karine. Nel disperato tentativo di uccidere la creatura, il pilota della navetta Faris, spara accidentalmente a diversi serbatoi infiammabili collocati a bordo della nave, provocando così un'esplosione che la uccide e distrugge completamente la navetta. Il Neomorfo riesce però a fuggire. Nel frattempo Hallett, rimasto anch'esso infettato dalle spore, rimane ucciso quando dalla sua bocca fuoriesce un secondo Neomorfo...
Questa è una recensione che definirei
necessaria ma non sufficiente: necessaria per il dato storico stesso
dell’uscita in sala di un’opera di Ridley Scott, maestro
indiscusso e indiscutibile, opera che riprende e continua la mitopoiesi di Alien,
cominciata nel lontanissimo 1979. Non sufficiente per motivi
intrinseci alla lunghezza media di una recensione, e per il suo
stile, che non può che essere ahimè un po' tecnico, scarsamente emotivo.
Questo film meriterebbe invece uno stile più poetico, letterario, meritando un “parlare come sognare”, se utilizziamo la
nota frase dello psicoanalista americano Thomas H. Ogden. Infatti
partirei col dire che “Alien Covenant” è un “sogno delle
origini”, o meglio un sogno che Scott fa sull' “origine” intesa come operatore concettuale e
culturale. Non solo cioè,
origine dell’uomo, oppure origine del male eccetera, ma anche
origine del Cinema, della visione, della capacità dell’uomo di
sognare, cioè di “ri-vedere” e di rielaborare continuamente, poeticamente la propria vita.
Una
delle prime associazioni che mi sono venute in mente mentre ero in
sala con mio figlio, mi ha rimandato infatti al libro di Philip Dick, “Ma
gli androidi sognano pecore elettriche?”, opera visionaria, che
parla del rapporto tra robotica e un’umanità ormai perduta nella
notte dei tempi, libro che è stato essenziale per la scrittura di
“Blade Runner”. Dicevo che il dato che mi è parso essenziale di
quest’ultimo film di Ridley Scott è il suo far convergere tutta la
sua potenza sinfonica verso il tema delle origini, “sognando” le
origini di quel primo Alien che abbiamo visto nel 1979. E’
un film che va visto almeno due volte, non ci si può accontentare di
vederlo una volta sola e poi averne un quadro sufficientemente chiaro
per poterlo valutare con tutta la serenità necessaria. Come una
sinfonia, appunto, occorre farne esperienza -emotiva, sensoriale,
cognitiva- adeguatamente immersiva, facendo sedimentare le sue molte
suggestioni e facendole agire col tempo dentro di noi.
Tutto sommato la trama è
semplicissima, riguarda l’esplorazione delle origini del mostro
alieno invincibile, dal sangue fatto di acido che compare nel primo
film della serie e contro cui Ripley-Sigourney Weaver si troverà a
combattere per lunghi anni. Queste origini risiedono, aldilà delle
varie forme di mutazione incontrate dal mostro sul suo cammino,
principalmente in una fantasia inconscia di onnipotenza. C’è un
qualcosa, da qualche parte, in un altrove sconosciuto – sembra
volerci dire insistentemente Scott in questo suo ultimo film- che spinge verso la realizzazione di una fantasia
di potere assoluto, incontrastato, famelico e onnivoro, un potere che desidera togliere di mezzo il senso del limite che caratterizza l’umano.
Tale limite, heideggerianamente rappresentato dalla morte, esperienza
che sottolinea continuamente la fragilità dell’uomo, lotta
altrettanto continuamente con l’illusione dell’eternità,
orizzonte non ancora conosciuto dall’uomo, ma, forse attingibile in
un futuro robotico-tecnologico. “Alien Covenant” ruota intorno a questa idea, insieme
fascinosa e terrificante: in fondo idea di derivazione
faustiana, laddove Ridley Scott diventa il nostro attuale Goethe
cinematografico a indicarci un Mefistofele che si trova all’interno del DNA
dell’uomo stesso. La prima introduttiva sequenza dove vediamo
l’androide David e suo padre, un umano, ci pone subito nel bel
mezzo di questa idea ispiratrice del film: negli intensi dialoghi tra
i due, venati da un sottile senso del tragico, cogliamo l'idea di un rispecchiamento
mortifero tra uomo e androide ultra-umano, e il significato profondo
di questo dialogo ci ritorna in mente solo a termine del film. Ridley
Scott dirige un'opera pluristratificata: uno dei molti strati è appunto costituito dal tema dei possibili tragici effetti
dello sviluppo scientifico-tecnologico, che tende di per sé ad
andare oltre l’umano attraverso la promessa seducente e onnipotente
dell’eternità, del controllo del Tempo. In estrema sintesi “Origine” e
“Telos” umani sono i
cardini centrali della poetica di questo film, e non so se questo vi
sembra poco.
Fatte queste preliminari e necessarie
premesse, veniamo ora alle considerazioni tecniche. Sul piano della
regia credo che Ridley Scott si sarebbe benissimo potuto fermare alla
sequenza della prima traumaticissima mutazione (nell'infermeria
della navetta in esplorazione sul pianeta sconosciuto, ammarata sul
lago e all'interno di scenari naturalistici a loro volta sinfonici,
wagneriani). Poteva fermarsi lì, e ci avrebbe già regalato molto.
Invece il nostro prosegue omericamente la sua storia, una specie di
metafora uliseea al contrario, al negativo, in cui sono gli androidi
a voler superare le Colonne d’Ercole, a dire “fatti non foste a
viver come bruti", ma dal loro intrinseco punto di vista, cioè
dall’interno del loro sogno "elettrico". Perchè, si sa, “gli androidi
sognano pecore elettriche” e di quello sono capaci. Ma torniamo
alla sequenza dell’infermeria: una sequenza epocale, da storia del
Cinema sci-fi, memorabile e da studiare lungamente, sia nei movimenti
di macchina, sia nel montaggio rapidissimo, chirurgico, privo della
pur minima sbavatura, che ci incolla allo schermo, opera di un Pietro
Scalia che è un vero mostro, come giustamente ci ricorda l’amica
Lucia Patrizi nella sua ottima recensione; sia nell’uso superbo,
raffinato
degli effetti speciali (realizzati da una
crew molto vasta); sia
nell’uso di una fotografia da parte di Dariusz Wolski all’inizio
dalle tonalità essenziali, quasi zen, della prima sequenza, per poi
virare al grigio-verde piuttosto saturato delle sequenze d’azione
sul pianeta: sequenze da “film di guerra”, che confluiscono
tutte, nella prima parte del film, giustappunto nell'infermeria, dove si
consuma il tragico parto alieno, e dove la luce ritorna ad essere
intensa, ipoilluminante, iperrealistica; sia,
per finire, attraverso un accompagnamento musicale (di un
ispiratissimo Jed Kurzel, musica che, soprattutto nella prima parte, diventa
co-protagonista di un’immersione emotivo-percettiva a mio avviso
unica nel suo genere (la sequenza del dispiegamento delle vele solari
dell’astronave dei coloni, accompagnata da un sonoro con leggere
trombe di sfondo, non ha nulla da invidiare secondo me a “2001
Odissea nello spazio”).
Tutti i comparti tecnici (scenografie
naturalistiche e cosmiche comprese) lavorano come in un perfetto
gioco d’orchestra che mi fa tornare ancora una volta al termine
“sinfonico”.
Due parole finali, su quelli che a me
appaiono essere gli unici difetti di un film peraltro ineccepibile, a
tratti grandioso, sempre abissale nella profondità di riflessione e
sottotestualità che si muovono sotto la superficie del visivo:
a) la
sceneggiatura di Dan O’Bannon e Ronald Sushett (su un soggetto di
John Logan e Dante Harper, e su una story rimaneggiata anche da Jack
Paglen e Michael Green quindi organizzata da ben sei mani) ,
contiene qualche buco, che naturalmente passa inosservato di fronte
al mastodontico e raffinato
lavoro di tutto il gruppo di produzione e post-produzione (vedansi le
sequenze in cui la nave madre si avvicina alla tempesta e nelle quali
i contatti con l’equipaggio sul pianeta non fanno minimamente emergere, inspiegabilmente, la gravità della situazione sul pianeta; oppure quelle in cui si
costruisce l’interazione tra
David e Walter; oppure le inquadrature di raccordo storico con
“Prometheus”, che potevano essere narrate in modo decisamente più
fluido);
b) il casting (a cura di Carmen Cuba),
che vede spiccare in modo sublime l’interpretazione di Michael
Fassbender, un algido e primitivamente mortifero David, ma che non è
capace di conferire particolare espressività ad altri personaggi, soprattutto in
Daniels (una Katherine Waterston che ci saremmo aspettata non diciamo
all’altezza di una Sigourney Weaver inarrivabile, ma un po' meno
melanconica e più determinata).
Come dicevo all’inizio, anche ora
che sto per concludere la mia recensione all’ultimo “figlio” di
Ridley Scott, sento che questo scritto non sia sufficiente, sebbene
necessario. Molte cose infatti andrebbero ulteriormente osservate,
come ad esempio il nesso (centrale) con “Prometheus”, oppure il
significato molto profondo, dalle valenze simboliche tutte da
analizzare, della sequenza relativa alla morte del capitano
dell’astronave – il film si apre infatti con un lutto, non
dimentichiamolo, e da quel lutto, da quella tragica assenza iniziale,
si sviluppa poi tutta la narrazione. Preferisco tuttavia accomiatare
il lettore con un senso di incompiuto, di insaturo, poiché, come la
poesia, anche il cinema, e soprattutto questo film, è vera poesia solo se
promuove aperture di senso e di pensiero.
Regia: Ridley Scott Soggetto e Sceneggiatura: Dan O’Bannon, Ronald Sushett, John Logan, Dante Harper Fotografia: Dariusz Wolski Montaggio: Pietro Scalia Musiche: Jed Kurzel Cast: Michael Fassbender, Katherine Waterstone, Billy Crudup, Danny McBride, Demian Bichir, Carmen Ejogo, Jussie Smollett, Callie Hernandez, Amy Saimetz, Nathaniel Dean, Uli Latukefu Nazione: UK, Australia, New Zealand, USA Produzione: Twenthieth Century Fox Film Corporation, Brandywine Productions, Scott Free Productions Durata: 2h e 2 min.
sabato 4 febbraio 2017
Split, di M. Night Shyamalan (2016)
Kevin (James McAvoy) è un individuo nel quale convivono ventitré differenti personalità, e le ha mostrate tutte alla sua psichiatra, l'anziana dottoressa Fletcher (Betty Buckley). Tutte tranne una, la ventiquattresima, nascosta, che sta lavorando nell'oscurità della sua mente per esprimersi e dominare su tutte le altre. Dopo aver sequestrato tre ragazze adolescenti, guidate da Casey (Anya Taylor-Joy), ragazza molto intelligente e coraggiosa, nella mente di Kevin comincia una vera battaglia tra le molte personalità che coabitano in lui e i confini instabili della sua identità cominciano lentamente ad andare in pezzi.
È
facile cadere nel ridicolo quando si mette al centro di uno script un
protagonista che contiene dentro di sé ben 23 personalità, cioè un
protagonista che di fatto è un paziente psichiatrico puro, affetto
da Disturbo di Personalità Multipla, secondo i criteri diagnostici
più diffusi e riconosciuti a livello internazionale. Si tratta,
inoltre, di una forma di patologia epidemiologicamente piuttosto
rara, dalle radici eziotologiche oscure, che si suole far risalire ad
abusi infantili gravi, ma anche su questo aspetto tutto è relativo
poiché il disturbo dipende quant'altri mai da una multifattorialitá
intrinseca nella storia di ciascun soggetto preso singolarmente.
Abbracciare un interesse psichiatrico di tale natura per un regista è
cioè, di per sé, una decisione quantomeno coraggiosa, per non dire
ardita, e che, se non portata avanti con un "grano salis"
adeguato, può certamente presto condurre sul confine del ridicolo.
M. Night Shyamalan prende un attore non particolarmente pregnante
come James McAvoy, lo rade a zero, lo veste e traveste variamente, e
lo piazza a dirigere l'orchestra di almeno 5 o 6 differenti
personalità (tra cui quella di Hedwig, un bambino di 9 anni),
affiancandolo per giunta a sole altre quattro co-protagoniste, di cui
una anziana Betty Buckley (la psichiatra del "mostro", cioè
la dottoressa Karen Fletcher). Messo
in piedi tutto questo circo è persino capace, non solo di non cadere
affatto nel ridicolo, ma per di più, di raggiungere una profondità
e di instillare a piene mani un senso di cupezza perturbante che non
si erano mai viste in nessuno dei suoi precedenti film.
Per operare
questo quasi-miracolo Shyamalan intanto genera,
fin dalle prime sequenze, una dialettica geometricamente perfetta tra
i caratteri delle due personalità più centrali della scena, e cioè
quello di Kevin e quello di Casey (Anya
Taylor-Joy), adolescente dallo sguardo scuro
come il suo passato, tempo antico che
Shyamalan ricostruisce a colpi di fini flashback collocati in forma
di agnizione graduale lungo il corso di tutta la storia. Tali flashback sono fotografati magistralmente da quel grande fotografo che aveva già svolto un gran lavoro in "It Follows" (2014), e cioè Michael Gioulakis. Un fotografo che sa davvero "fotografare" le luci e le ombre dell'adolescenza quant'altri mai.
La
sconvolgente simmetria personologica tra Casey e Kevin, la risonanza
profonda tra queste due personalità così diverse e insieme simili,
la scopriamo tuttavia solo nel prefinale, che ci colpisce come una
martellata su un piede, ma é questo il cuore del film, il suo
compimento giustamente spiazzante, e
amaro, molto amaro, tanto che vorremmo vomitarlo fuori al più presto
se potessimo questo orrido boccone,
ma non possiamo farlo, ahimè.
Il tema dell'abuso perpetrato da adulti folli su minori fragili e
indifesi per costituzione ed etá sembra essere molto caro a
Shyamalan, perché anche nel suo precedente "The visit"
(2015), avevamo
visto capovolgersi le consuete trame affettive che vedono di solito
nonni e nipoti avvolti in un amorevole abbraccio. In "Split"
questo capovolgimento è
denunciato a caratteri cubitali, forse anche mediante la scelta di un
personaggio davvero "cubitale" come appunto Kevin. La sua
24esima personalità emergente, che lui stesso e la sua psichiatra,
la dottoressa
Fletcher, chiamano "La Bestia", infatti non appartiene in
realtà a lui, al tessuto della sua personalità, bensì a quella del
suo abusatore: si tratta cioè di una "identificazione con
l'aggressore" (Ferenczi, 1932).
In questo plot così fosco, scritto completamente dallo stesso Shyamalan, tutto centrato sul l'esito di traumi psicologici e fisici perpetrati a
gravissimo danno
dell'infanzia, grande, grandissima
rilevanza possiede la caratterizzazione della dottoressa
Fletcher, psicoterapeuta che si muove certamente in un alveo teorico
psicoanalitico. Shyamalan riesce a costruire i densi e profondissimi
dialoghi tra la dottoressa e Kevin, durante le loro sedute, con
finezza incredibile, soprattutto agli occhi di uno psicoanalista,
poiché in quei colloqui c'è davvero studio e tecnica
psicoterapeutica non da poco. La Fletcher accompagna Kevin attraverso
il labirinto delle sue scissioni multiple interne, con modalità
niente affatto lontane da quelle utilizzate realmente da un terapeuta
di oggi con un suo paziente anche grave come Kevin. E
lo accompagna come prendendo davvero per mano un bambino solo e
disperato, di stanza in stanza, nella sua casa degli orrori interna.
La finezza empatica dimostrata dalla Fletcher e
sottolineata dai notevoli, a volte insistenti primi piani di una
bravissima Betty Buckley, raccontano il lavoro mentale immersivo e
difficilissimo che un terapeuta svolge tutti i giorni nel suo studio,
un racconto molto
più significativo e potente di quelli raccontati nella tanto
osannata serie televisiva di "In Treatment".
Insomma,
Shyamalan ha dei numeri nel descrivere sia la patologia che la cura,
mostrandone la dialettica insieme simmetrica e asimmetrica, elemento
che non si ritrova così facilmente in certo cinema che vuole
rappresentare ad esempio la psicoanalisi. In questo senso "Split"
è fortemente un film sulla psicoterapia intesa davvero come un
"Dangerous Method", per parafrasare il notissimo film di
David Cronenberg
su Jung del 2011.
Ritengo che se "A Dangerous Method" fosse un film notevole
sul piano della ricostruzione storica del metodo psicoanalitico,
"Split" è sommamente la rappresentazione plastica
dell'esperienza reale di una psicoterapia, con tutti i suoi
slittamenti intersoggettivi benigni
ma anche maligni che avvengono tra paziente e terapeuta, slittamenti
che possono diventare smottamenti e terremoti, perché mossi
essenzialmente da quella "Bestia" pericolosissima è
distruttiva che è il trauma infantile.
La giovane Casey e la sua
storia sono in
questo senso raccontate
con grande poesia e intensità
da uno Shyamalan, che, nel descrivere nello
specifico la figura dello zio John,
sembra proprio voler denunciare il tema dell'abuso, neanche come
"sottotesto", ma come testo dichiarato, seppur in un
contesto di cinema di fiction. La storia di Casey è, anche in questo
caso, molto realistica, una storia cioè che ai terapeuti (come il
sottoscritto) che lavorano spesso
con ragazzi abusati e traumatizzati, risulta purtroppo molto
familiare, cioè per nulla "cinematografica", nonché
raccontata con venature pessimistiche, per nulla edulcorate, come
dimostrano le ultime sequenze composte dalle inquadrature di Casey,
tristemente seduta su una automobile della polizia, luogo
rappresentativo di una Legge che dovrebbe alfine proteggerla, ma che
in realtà non la protegge affatto.
Shyamalan raggiunge una grande
maturità di pensiero e di poetica in questo suo film, che ha inoltre
il merito non secondario di fornire un' immagine autentica, realmente operativa della psicoanalisi e della psicoterapia, nonché della
lotta disperata dell'individuo contro il male che gli può essere
inflitto proprio dalle persone che dovrebbero amarlo di più, e
che si deposita dentro di lui, come una “bestia”, distruggendolo.
"Split" è dunque un film
da vedere, più e più volte per poi discuterne insieme lungamente
con amici, parenti, colleghi - anche non psicoanalisti.
Regia: M. Night Shyamalan Soggetto e Sceneggiatura: M.Night Shyamalan Fotografia: Michael Gioulakis Cast: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Jessica Sula, Haley Lu Richardson, Brad William HenkeSebastian Arcelus Nazione: USA Produzione: Blinding Edge Pictures, Blumhouse Productions Durata: 1 h e 57 min.
Iscriviti a:
Commenti (Atom)