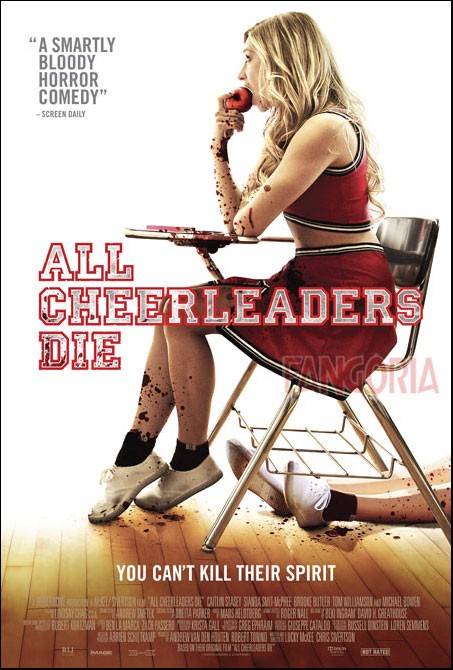In un futuro non lontano due bio-ingegneri esperti in intelligenza artificiale, lavorano insieme per costruire il primo prototipo di cyborg dotato di autocoscienza. Vincent, l'ingegnere più anziano, spera segretamente di poter sviluppare una tecnologia per aiutare sua figlia, affetta da una grave sindrome neurologica, sebbene questo significhi per lui accettare dei finanziamenti dal potente e spregiudicato Ministro della Difesa che si trova impegnato in una sorta di nuova Guerra Fredda contro la Cina. La nuova compagna di Vincent, Ava, scopre alcuni insospettabili segreti all'interno del database del Ministero e viene così uccisa dagli agenti del controspionaggio. Nel frattempo il Ministro decide di porre in essere un piano militare di cui aveva tenuti nascosti i particolari a Vincent, allo scopo di trasformare i cyborg in micidiali macchine da guerra...
Continuiamo il nostro percorso all'interno del cinema sci-fi/horror anglosassone contemporaneo, ed ecco che ci imbattiamo in questo "The Machine" del giovane regista gallese Caradog W. James. Film molto british, completamente (ed orgogliosamente) low-budget, intenso in alcune sequenze, discutibile in altre, ma che comunque riflette una vitalità del cinema europeo che dalle nostre parti semplicemente possiamo solo sognarci, di notte. La storia è di una linearità quasi disarmante: Vincent è un ingegnere specializzato in biotecnologie avveniristiche centrate sulla creazione di umanoidi militari utilizzati dal Ministero della Difesa inglese per combattere una nuova guerra fredda contro la Cina. L'uomo è interpretato da un Toby Stephens (lo avevamo visto in Space Cowboys di Clint Eastwood, 2000) intimistico e dalla faccia stropicciata e quasi sempre sofferente. Sua figlia è affetta da Sindrome di Rett, una grave malattia neurologica infantile di tipo congenito, e lui la accudisce da solo, senza cioè figure femminili di sorta.
Questa base esistenziale molto dura e senza sconti lo porta a sottostare ai voleri di Mister Thomson, il freddo e spregiudicato funzionario del Ministero della Difesa, che utilizza le sue sopraffine conoscenze per manipolare cyborg e prepararli alla guerra. Questo patto, mai esplicitato chiaramente nel film, ma sottilmente sempre presente come un mortifero background, consente a Vincent di portare avanti i suoi studi nel disperato tentativo di trovare una cura idonea per sua figlia. L'aspetto interessante del film consiste nel fatto che James riesce a incastonare questo filone appunto intimistico del suo script, all'interno di un'ambientazione che si situa per la quasi totalità del girato nei laboratori militari segreti del Ministero della Difesa inglese: ogni tanto compiano sequenze in cui vediamo Vincent con la figlia, ma sono sempre molto brevi, sebbene molto intense, soprattutto nella rappresentazione della sintomatologia di cui è affetta la bambina. Sia il montaggio (di Platts-Mills) che il lento andamento della storia, alternano morbidamente i due principali filoni del racconto (complotto fantascientifico e relazione padre-figlia) facendoli coesistere senza eccessi di intimismo da una parte, o di azione e violenza dall'altra.
Lo script possiede un carattere complessivo di tipo drammaturgico-teatrale, tanto che potrebbe, io credo, essere tranquillamente tradotto a teatro, così com'è. A James interessano infatti le interazioni, non certo le azioni, che lo spettatore si aspetterebbe, come un bambino che vuole vedere se Babbo Natale ha portato i doni belli impacchettati sotto l'albero. James prende per mano questo bambino e con gentilezza lo accompagna fuori dalla stanza spiegandogli educatamente che Babbo Natale non esiste. Da questo punto di vista "The Machine" può risultare piuttosto freddo, ma d'altra parte l'opera di James discute proprio di "coscienza", pur toccando temi cari alla cultura (sia cinematografica che letteraria) anglosassone, come quello del pigmalionismo (nel film si coglie un pigmalionismo al contrario, in verità). Si tratta di un mitema che ha interessato, ricordiamo, ad esempio Edgar Allan Poe, ma soprattutto George Bernard Shaw. James sembra guardare a quel mitema e lo fa in modo originale, in continuità coi suoi illustri predecessori, ma in qualche modo anche rinnovandolo mediante la sua inserzione in ambito sci-fi.
Un'ulteriore pregio del film è che propone un finale aperto, con quella sequenza dove domina un sole che non capiamo se sia al tramonto oppure sorga, e nel quale comunque domina l'idea di una nuova nascita, quella della donna umanoide che alla fine ha davvero coscienza dei suoi sentimenti, addirittura del suo amore nei confronti dell'uomo. Questo tema è a mio avviso trattato con una certa finezza, da parte del regista, e permette l'accensione di riflessioni interessanti nella mente dello spettatore. Una di queste riflessioni può ben riguardare il tema del narcisismo imperante (la Sindrome di Rett può dunque essere vista anche come metafora molto pregnante delle difficoltà di riconoscimento delle proprie emozioni da parte dell'uomo contemporaneo, nonché dei problemi di comunicazione ai propri simili di tali emozioni. Si tratta di un vasto arcipelago clinico che riguarda le cosiddette "nuove patologie" che la psicoanalisi contemporanea sta osservando, curando e studiando da un pò di tempo a questa parte). Da una prospettiva psicoanalitica potremmo dire che in questo suo film James si pone una domanda cruciale circa la possibilità di Ava, trasformata in umanoide, di uscire dal proprio narcisismo robotico e di sperimentare un transfert nei confronti di un Vincent-analista (è la stessa domanda che spesso gli analisti si pongono di fronte a certi pazienti chiusi in corazze narcisistiche molto coriacee). Perché la risposta a questa domanda sul transfert sia positiva, occorre che un bambino simbolicamente muoia (la figlia di Vincent), cioè che l'analista-scienziato elabori con attenzione il suo controtransfert, le sue emozioni, i propri lutti interni: si lasci cioè "toccare" e trasformare a sua volta dalle modalità aliene del transfert di Ava.
"The Machine" risente notevolmente di un budget ridottissimo, sebbene James non rincorra affatto la spettacolarità dell'effetto speciale, ma anzi lo sappia usare con finalità anzi finemente estetiche (si veda la sequenza della danza di Ava tra le pozze d'acqua mentre il suo corpo si illumina di scariche elettriche di colore rosso). Viene quasi da pensare che i pochi momenti d'azione siano del tutto superflui, e che in qualche modo James li abbia voluti inserire per omaggiare la produzione, che gli ha pur consentito di installare il suo dispositivo cinematografico.
Aldilà di certe lentezze, di alcune ingenuità proprio nelle sequenze d'azione, di una certa povertà d'insieme dell'allestimento scenografico, e di una colonna sonora (di un Tom Raybould ahimè molto piatto e per niente ispirato) a tratti completamente dissintona rispetto al visivo che accompagna, in definitiva "The Machine" rimane un interessante esperimento, forse un pò freddo, forse un pò troppo asciutto per chi non è nato e cresciuto a Cardiff, ma che è in ogni caso da vedere anche per cogliere il buono stato di salute del cinema inglese di oggi.
Continuiamo il nostro percorso all'interno del cinema sci-fi/horror anglosassone contemporaneo, ed ecco che ci imbattiamo in questo "The Machine" del giovane regista gallese Caradog W. James. Film molto british, completamente (ed orgogliosamente) low-budget, intenso in alcune sequenze, discutibile in altre, ma che comunque riflette una vitalità del cinema europeo che dalle nostre parti semplicemente possiamo solo sognarci, di notte. La storia è di una linearità quasi disarmante: Vincent è un ingegnere specializzato in biotecnologie avveniristiche centrate sulla creazione di umanoidi militari utilizzati dal Ministero della Difesa inglese per combattere una nuova guerra fredda contro la Cina. L'uomo è interpretato da un Toby Stephens (lo avevamo visto in Space Cowboys di Clint Eastwood, 2000) intimistico e dalla faccia stropicciata e quasi sempre sofferente. Sua figlia è affetta da Sindrome di Rett, una grave malattia neurologica infantile di tipo congenito, e lui la accudisce da solo, senza cioè figure femminili di sorta.
Questa base esistenziale molto dura e senza sconti lo porta a sottostare ai voleri di Mister Thomson, il freddo e spregiudicato funzionario del Ministero della Difesa, che utilizza le sue sopraffine conoscenze per manipolare cyborg e prepararli alla guerra. Questo patto, mai esplicitato chiaramente nel film, ma sottilmente sempre presente come un mortifero background, consente a Vincent di portare avanti i suoi studi nel disperato tentativo di trovare una cura idonea per sua figlia. L'aspetto interessante del film consiste nel fatto che James riesce a incastonare questo filone appunto intimistico del suo script, all'interno di un'ambientazione che si situa per la quasi totalità del girato nei laboratori militari segreti del Ministero della Difesa inglese: ogni tanto compiano sequenze in cui vediamo Vincent con la figlia, ma sono sempre molto brevi, sebbene molto intense, soprattutto nella rappresentazione della sintomatologia di cui è affetta la bambina. Sia il montaggio (di Platts-Mills) che il lento andamento della storia, alternano morbidamente i due principali filoni del racconto (complotto fantascientifico e relazione padre-figlia) facendoli coesistere senza eccessi di intimismo da una parte, o di azione e violenza dall'altra.
Lo script possiede un carattere complessivo di tipo drammaturgico-teatrale, tanto che potrebbe, io credo, essere tranquillamente tradotto a teatro, così com'è. A James interessano infatti le interazioni, non certo le azioni, che lo spettatore si aspetterebbe, come un bambino che vuole vedere se Babbo Natale ha portato i doni belli impacchettati sotto l'albero. James prende per mano questo bambino e con gentilezza lo accompagna fuori dalla stanza spiegandogli educatamente che Babbo Natale non esiste. Da questo punto di vista "The Machine" può risultare piuttosto freddo, ma d'altra parte l'opera di James discute proprio di "coscienza", pur toccando temi cari alla cultura (sia cinematografica che letteraria) anglosassone, come quello del pigmalionismo (nel film si coglie un pigmalionismo al contrario, in verità). Si tratta di un mitema che ha interessato, ricordiamo, ad esempio Edgar Allan Poe, ma soprattutto George Bernard Shaw. James sembra guardare a quel mitema e lo fa in modo originale, in continuità coi suoi illustri predecessori, ma in qualche modo anche rinnovandolo mediante la sua inserzione in ambito sci-fi.
Un'ulteriore pregio del film è che propone un finale aperto, con quella sequenza dove domina un sole che non capiamo se sia al tramonto oppure sorga, e nel quale comunque domina l'idea di una nuova nascita, quella della donna umanoide che alla fine ha davvero coscienza dei suoi sentimenti, addirittura del suo amore nei confronti dell'uomo. Questo tema è a mio avviso trattato con una certa finezza, da parte del regista, e permette l'accensione di riflessioni interessanti nella mente dello spettatore. Una di queste riflessioni può ben riguardare il tema del narcisismo imperante (la Sindrome di Rett può dunque essere vista anche come metafora molto pregnante delle difficoltà di riconoscimento delle proprie emozioni da parte dell'uomo contemporaneo, nonché dei problemi di comunicazione ai propri simili di tali emozioni. Si tratta di un vasto arcipelago clinico che riguarda le cosiddette "nuove patologie" che la psicoanalisi contemporanea sta osservando, curando e studiando da un pò di tempo a questa parte). Da una prospettiva psicoanalitica potremmo dire che in questo suo film James si pone una domanda cruciale circa la possibilità di Ava, trasformata in umanoide, di uscire dal proprio narcisismo robotico e di sperimentare un transfert nei confronti di un Vincent-analista (è la stessa domanda che spesso gli analisti si pongono di fronte a certi pazienti chiusi in corazze narcisistiche molto coriacee). Perché la risposta a questa domanda sul transfert sia positiva, occorre che un bambino simbolicamente muoia (la figlia di Vincent), cioè che l'analista-scienziato elabori con attenzione il suo controtransfert, le sue emozioni, i propri lutti interni: si lasci cioè "toccare" e trasformare a sua volta dalle modalità aliene del transfert di Ava.
"The Machine" risente notevolmente di un budget ridottissimo, sebbene James non rincorra affatto la spettacolarità dell'effetto speciale, ma anzi lo sappia usare con finalità anzi finemente estetiche (si veda la sequenza della danza di Ava tra le pozze d'acqua mentre il suo corpo si illumina di scariche elettriche di colore rosso). Viene quasi da pensare che i pochi momenti d'azione siano del tutto superflui, e che in qualche modo James li abbia voluti inserire per omaggiare la produzione, che gli ha pur consentito di installare il suo dispositivo cinematografico.
Aldilà di certe lentezze, di alcune ingenuità proprio nelle sequenze d'azione, di una certa povertà d'insieme dell'allestimento scenografico, e di una colonna sonora (di un Tom Raybould ahimè molto piatto e per niente ispirato) a tratti completamente dissintona rispetto al visivo che accompagna, in definitiva "The Machine" rimane un interessante esperimento, forse un pò freddo, forse un pò troppo asciutto per chi non è nato e cresciuto a Cardiff, ma che è in ogni caso da vedere anche per cogliere il buono stato di salute del cinema inglese di oggi.
Regia: Caradog W. James Soggetto e Sceneggiatura: Caradog W. James Fotografia: Nicolaj Bruel Montaggio: Matt Platts-Mills Musiche: Tom Raybould Cast: Caity Lotz, Toby Stephens, San Hazeldine, Denis Lawson, Pooneh Hajimohammadi, Lee Nicholas Harris, Sule Rimi, Ben McGregor Nazione: UK Produzione: Red & Black Films Durata: 91 min.