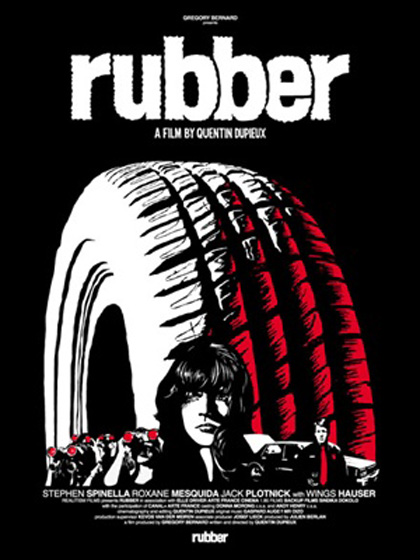La giovane Marybeth riesce a scappare dalla palude dove vive il leggendario e sanguinario Victor Crowley ma, non contenta di essere sopravvissuta, convince il reverendo Zombie di New Orleans ad accompagnarla di nuovo nel covo del mostro per recuperare i resti dei suoi familiari. Organizzato un nuovo gruppo di spedizione, Zombie rivela ben altri progetti rispetto a quello di eliminare il terribile Crowley...
Voglio pensare che Adam Green, con questo secondo capitolo di "Hatchet", abbia voluto riposarsi, dopo le fatiche e l'energia profusa in "Frozen", abbia voluto cioè dedicarsi a un divertissement senza pretese particolari, poichè di questo si tratta, cioè di un film poco ispirato e anche un tantino monocorde. Le spinte filologico-ricostruttive del cinema anni '80, della "old school american horror", delle radici arcaiche dello "slasher", presenti ed egregiamente operanti nel primo episodio, sono qui certo presenti, ma trattate con superficialità. Ad esempio le sequenze splatter sono orchestrate e condotte in modo troppo automatico e freddo, così che non trasmettono nessuna sensazione, nè tantomeno inducono a particolari riflessioni circa il tema del corpo martirizzato e dissezionato, anche nelle sue valenze più sessualmente exploitate. Nonostante il cast sia assolutamente perfetto, e si muova fin dalle prime sequenze con autoironica e ponderata leggiadria, lo script procede lungo un percorso stancamente risaputo che evolve in successivi climax durante i quali il mostro-bambino Victor Crowley, ormai cresciuto anche come fantasma di se stesso, compare dalla giungla paludosa con la sua motosega iper-mega-fallica, immagine condensata di un padre-figlio primordiale castrante, ma nulla più. Tutto vira velocemente al grottesco, all'eccessivo, al grandguignolesco, ma sempre senza emozionare, spaventare, consentire uno straccio di identificazione. E' in questo senso che penso che "Hatchet II" sia da ritenersi un semplice momento di pausa per un Green che abbiamo visto decisamente più in forma, per esempio nell'ottimo "Frozen" (2010). E' come se Green si fosse cioè messo a giocare un attimo al computer, tanto per far passare il tempo, prima di tornare in ufficio. Come al solito la fotografia di Will Barratt è molto suggestiva e precisa nel rendere le location delle paludi di New Orleans, e direi che vale la pena di vedere il film anche per gustarsi questo elemento visivo-naturalistico che davvero è un piacere per gli occhi. L'attenzione per la natura selvaggia, nonchè una sua rappresentazione che si fa molto viva e presente nei suoi film, sono peraltro degli elementi importanti della poetica filmica di Green, e vanno dunque analizzati e osservati con attenzione. Per concludere, possiamo dire che "Hatchet II" va certamente visto per capire l'evoluzione artistica di un regista che ha cominciato un suo percorso di sperimentazione e ricerca appunto ancora iniziali, ma che fanno ben sperare nei loro sviluppi futuri. Tuttavia non siamo certo di fronte all'opera più riuscita di Green. Regia: Adam Green Sceneggiatura: Adam Green Fotografia: Will Barratt Montaggio: Ed Marx Musica: Andy Garfield Interpreti: Danielle Harris, Kane Hodder, Tony Todd, Parry Shen, Tom Holland, R.A. Mihailoff, AJ Bowen, Kathryn Fiore Nazione: USA Produzione: Dark Sky Films, Ariescope Pictures Anno: 2010 Durata: 89 min.